In seguito al presidio di sabato 23 marzo davanti al carcere di Ferrara, si rendono necessarie alcune considerazioni.
Durante l’iniziativa alcune urla si sono librate nell’aria. Le abbiamo accolte con gioia, pensando che qualche detenuto apprezzasse la nostra presenza solidale.
Da Alfredo e Sergio apprendiamo, purtroppo, che quelle che avevamo scambiato per esternazioni di gioia altro non erano se non lamentele, “colorate” per di più da cori fascisti ed insulti sessisti. Quel giorno, infatti, la direzione del carcere aveva vietato i colloqui per tutta la popolazione reclusa, così come l’ora d’aria.
Ora, non ci è dato sapere se tali lamentele provenissero dalla sezione dei cosiddetti “collaboratori di giustizia” (ossia gli infami) o dai detenuti “comuni”. Se quelle urla di disappunto provenivano dagli infami, o magari dagli assassini di Federico Aldrovandi alloggiati all’Arginone, speriamo che ci si siano strozzati. Ovviamente la nostra solidarietà non era estesa a loro.
Se, al contrario, erano manifestazioni di stizza di detenuti non collaboratori il problema è ben più a monte.
Comprendendo lo sconforto seguito alla revoca dei colloqui con i propri cari e dell’ora d’aria, non possiamo però capire come ci si possa lamentare di una presenza solidale, e non solo con i compagni, sotto un luogo che rinchiude gli individui.
E qui si deve aprire uno spazio di riflessione, per quanto “doloroso” esso possa apparire.
Dobbiamo pur renderci conto che una oggettiva condizione di esclusione, fisica al pari che sociale, non determina per forza la voglia di lottare in uno o più individui né li “classifica” come soggetti rivoluzionari. (E questa ovviamente è una considerazione che travalica il discorso carcerario).
Il nostro anelito per la libertà, che si esplica anche nella volontà di distruggere qualunque prigione, ci spinge a cercare complici in tutti quegli individui e in tutte quelle categorie che soffrono di una limitazione maggiore di tale libertà. Per cui, ovviamente, siamo al fianco dei detenuti e lottiamo per la distruzione di ogni prigione.
Ma dobbiamo anche trovare quella lucidità che ci permetta di vedere quanto anche un escluso possa non essere un compagno di lotta.
Una situazione in cui l’esclusione e lo sfruttamento siano estremizzati, come ad esempio la condizione di carcerato, non significa assolutamente che chi vive tale situazione voglia intraprendere un percorso conflittuale di rottura e di attacco. Anzi, a volte, può portare all’opposto, ossia ad un misero tirare a campare per quel poco che si ha, aggrappandosi a quell’unica cosa che ormai si possiede, ossia la catena che lega i polsi.
Condizioni estreme di sopravvivenza possono evolvere in esplosioni di rabbia, ma anche in un arroccamento nella propria miseria, per cui il poco che ancora ci rimane – quel poco che ci viene concesso (il colloquio settimanale, l’ora d’aria giornaliera, ecc. ma anche il quieto vivere) – va tutelato ad ogni costo,passando anche sulla pelle di chi se la vive pure peggio.
Finisce quindi che la guerra tra poveri aizzata dal potere abbia la meglio. Che il gioco della direzione del carcere di mettere i detenuti gli uni contro gli altri passi impunemente. E che la solidarietà nei confronti di compagni rinchiusi in regime di alta sorveglianza, e dei detenuti in quanto tali, diventi un ostacolo alla routine del tirare a campare “comune” degli altri ristretti in carcere.
Per cui la prospettiva della lotta anticarceraria, al pari di qualunque altro sentiero di scontro, va sviluppata tenendo bene a mente qual è la cruda realtà dei fatti.
Possiamo, e dobbiamo, batterci perché delle galere non rimangano nemmeno le macerie, ma non possiamo concederci il lusso di aspettarci di avere tutti i detenuti, intesi come “classe”, al nostro fianco in questa battaglia. I lodevoli esempi di Tolmezzo e di Saluzzo non sono l’eccezione che conferma la regola ma quasi. Sono comunque situazioni in cui la lotta contro il carcere può svilupparsi in modi ancora piacevolmente imprevedibili, forse.
Come sempre, i complici si individuano in base all’affinità d’intenti e di pratica, non pescandoli a caso nel mare della semplice e spietata oppressione (e reclusione).
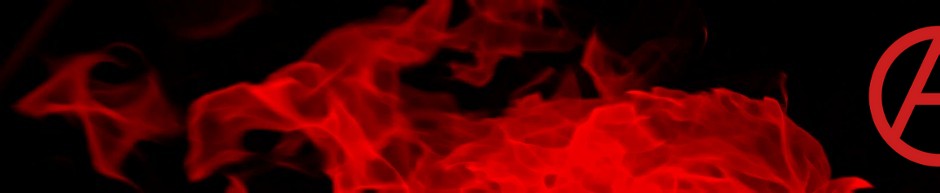
 http://anarchiciferraresi.tk
http://anarchiciferraresi.tk